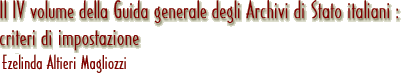
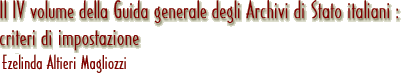
Ufficio centrale per i beni archivistici - Divisione Studi e Pubblicazioni *
Con la pubblicazione del quarto volume della Guida generale degli
Archivi di Stato italiani viene a completarsi il quadro descrittivo di tutto il materiale
documentario conservato nei nostri istituti e viene a concludersi una esperienza
lavorativa che segna una tappa fondamentale nella nostra storia archivistica.
È stato questo della Guida un lavoro lungo e travagliato che ha visto seriamente
impegnati i coordinatori al centro e i collaboratori in periferia in un concorde e
proficuo scambio di esperienze; confronti-scontri accesissimi, sia nella fase progettuale
- quando si è trattato di decidere l'impianto generale, l'organizzazione e la struttura
da dare alla «Guida delle guide»(1) sia nella fase operativa, quando si è trattato di
calare nella realtà le «Istruzioni» impartite dal centro. Lavoro pilota, di
impostazione innovativa, oseremmo dire rivoluzionaria, se si pensa che gli ideatori
dell'opera, e con essi i direttori dei diversi istituti, si ponevano per la prima volta
quei problemi di normalizzazione descrittiva che sono oggi al centro del dibattito
internazionale. Problemi complessi, relativi sia alla sintassi - attinenti cioè al modulo
organizzativo degli istituti archivistici e dei fondi in essi conservati - che alla
grammatica - attinenti cioè ai criteri di rilevazione dei dati e di presentazione delle
informazioni, quelli che con linguaggio moderno potremmo definire standard di
rappresentazione, «data structure standards», e standard di descrizione,
«data content standards»(2).
Per quanto riguarda l'impianto generale dell'opera, è noto che è risultata
vincente la linea che prediligeva una impostazione chiara, schematica, di facile lettura,
realizzata sia tramite la disposizione delle «voci», relative ai singoli Archivi di
Stato secondo l'ordine alfabetico(3) , sia tramite la scelta di una griglia entro cui
articolare la disposizione dei fondi. Griglia basata su criteri di periodizzazione storica
per la parte prima e seconda di ogni singola «voce», rispettivamente dedicate
all'illustrazione degli archivi di organi e istituti statali preunitari e postunitari; su
parametri di classificazione per così dire tipologici per la parte terza, destinata ad
accogliere fondi di istituti non statali o non periodizzabili secondo «le grandi
linee dello sviluppo della storia generale e istituzionale dei singoli Stati
italiani», raggruppati sotto categorie ispirate «a fatti archivistici, a
situazioni storiche, o a peculiarità istituzionali»(4). Griglia descrittiva questa, atta a garantire
facilità di lettura e unitarietà di impostazione, sorta di impalcatura architettonica
entro cui collocare una realtà archivistica nazionale quanto mai difforme, poliedrica,
sfaccettata, ricondotta in questo modo a omogenei parametri di descrizione.
Alcuni archivisti hanno visto in questa griglia periodizzante, una sorta di
camicia di Nesso(5) che ingabbiava e mortificava la ricca fenomenologia
dei fondi. Altri hanno criticato proprio gli obiettivi sottesi alla scelta di uniformità
descrittiva, percepita come pericolosamente vicina al concetto settecentesco di facilitare
le ricerche(6). In realtà, I'uniformità descrittiva tanto
criticata è solo l'intelaiatura, il filo di Arianna che guida il percorso, poiché le
norme che stabilivano i criteri guida per il censimento e la descrizione del materiale
documentario riproponevano il più ortodosso dei principi archivistici: il rispetto del
principio di provenienza(7).
Chiare le direttive impartite al riguardo: i fondi dovevano essere illustrati nella loro
unitarietà e nella loro originaria provenienza senza tener conto "delle divisioni in
sezioni stabilite dal regolamento del 1911 (sezione giudiziaria, amministrativa e
notarile); delle divisioni topografiche (neanche per gli Archivi di Stato che hanno più
sedi); di ogni altra divisione estrinseca, come ad esempio quelle che derivano dal titolo
giuridico di ingresso nell'Archivio di Stato («dono», «acquisto» e
simili). Le uniche eccezioni ammesse riguardavano le collezioni, le raccolte, le
miscellanee consolidate, e i riordinamenti per materia effettuati col metodo cosiddetto
«peroniano» da considerare ormai irreversibili(8).
Scelta quindi di un criterio rigidamente archivistico di individuazione-ricostituzione del nesso esistente tra i fondi e i soggetti che li hanno prodotti che
presuppone il pieno dominio intellettuale dei fondi stessi per poter distinguere quanto
attiene alla struttura, all'ordine formale della memoria dell'ente e quanto attiene a
sovrastrutture dovute a disordine, incuria e arbitrari rimaneggiamenti che alterano la
vera fisionomia dei fondi.
Dunque una meta ambiziosissima quella proposta dagli ideatori della Guida: i
collaboratori, ispirandosi «a quel metodo storico che, pur nella varietà delle
interpretazioni e degli adattamenti, è ormai accettato come canone fondamentale dalla
archivistica in Italia», dovevano cercare di ricostruire «l'integrità e la
continuità delle serie» allo scopo di arrivare a collocare il documento nel contesto
che lo vide nascere. L'essenza della descrizione dunque viene correttamente ricondotta
alla contestualizzazione del dato archivistico, alla correlazione delle serie «quale
prima garanzia di omogeneità e comparabilità dei dati»(9).
Per quando riguarda la descrizione vera e propria possiamo individuare nelle
«Istruzioni» diramate per l'elaborazione della Guida generale regole riferibili
a standard di rappresentazione: come strutturare la descrizione, quali le tipologie
informative e i dati da rilevare per ciascuna tipologia (Istituto: dati estrinseci:
servizi annessi all'istituto; dati globali e riassuntivi anche per la biblioteca
dell'istituto; introduzione generale; bibliografia generale. Inquadramento dei fondi:
partizioni storiche e partizioni tipologiche per fornire tutta una serie di informazioni
«di contesto» e sulla storia politico-istituzionale-territoriale degli antichi
Stati e sulle modalità di formazione dei fondi. Fondo: dati relativi a denominazione;
consistenza; limiti cronologici della documentazione in esso compresa; mezzi di corredo;
notizie storico-istituzionali e/o notizie biografiche sul soggetto (o soggetti) produttori
del fondo; notizie storico-archivistiche sulle modalità di formazione e di ordinamento
del fondo; riferimenti a documentazione collegala contenuta in altri fondi dell'istituto o
in istituti diversi; bibliografia specifica); e regole che possiamo riferire a standard di
descrizione: quali i criteri formali di presentazione delle informazioni, quali le
convenzioni grafiche da adottare per rendere immediatamente leggibili sia le relazioni tra
i fondi (aggregazioni di primo livello - superfondo - aggregazioni di secondo livello -
supersuperfondo -) sia la struttura organizzativa interna al fondo stesso (raggruppamenti
di serie, serie, sottoserie, eventuali ulteriori sottopartizioni).
Indicatori dunque di duplice relazione, per poter abbracciare il principio di
provenienza in tutte le sue possibili interpretazioni - non a caso si è sempre
sottolineato l'accezione «pragmatica» di termini chiave quali serie(10), fondo, archivio - e al contempo
per poter evidenziate tutte le relazioni che esistono nelle descrizioni inventariali, le
quali riflettono la grande varietà dei criteri che hanno presieduto nei secoli
all'organizzazione e al riordinamento del materiale.
Dunque convenzioni grafiche e convenzioni terminologiche quanto mai flessibili in
sintonia con gli obiettivi indicati dalla Guida: descrizione-rappresentazione dello stato
dei fondi qualunque esso fosse: ordinato, parzialmente ordinato, non ordinato.
Scorrendo le «voci» del quarto volume scopriamo un universo archivistico quanto
mai articolato e frastagliato, in cui tutta la complessa fenomenologia dei fondi che
qualcuno temeva potesse risultare appiattita da input di rilevazione così omogenei
risulta in tutta la sua interezza. Esempi significativi in tal senso possono considerarsi
le «voci» Siena, Venezia e Torino.
Il riordinamento dei fondi dell'Archivio di Stato di Siena, eseguito nel pieno rispetto
del metodo storico, ha comportato che ciascun fondo rispecchiasse nella sua interezza
l'ufficio che lo ha prodotto. A Venezia, in conseguenza della complessa situazione
istituzionale della Serenissima e dei modi di sedimentazione delle carte, il fondo
rispecchia l'attività di più organi, di più magistrati o di più uffici, dotati di
competenze convergenti e che spesso operavano in connessione reciproca, talché il nome
del fondo viene a legarsi con i nomi dei diversi istituti i cui archivi sono compresi nel
fondo stesso. A Torino i fondi dell'archivio di Corte, soggetto fin dai tempi più antichi
a riordinamenti per «materie» non sono legati al principio di provenienza ma a
quello di pertinenza.
Chiudo questa panoramica sull'impostazione generale di un'opera che ha dato
attuazione ad un programma audace, che anziché insabbiarsi ha visto accrescere sempre
più la mole dei volumi man mano editi, riportando le parole di una collega che si è
molto impegnata su questo fronte: «ho amato la Guida, è stata un mezzo per
appropriarmi dell'Istituto e una occasione di crescita professionale»(11). Parole che credo riflettano un
sentire comune di tutti coloro che hanno unito i loro sforzi per la realizzazione della
Guida generale degli Archivi di Stato italiani.