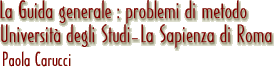
Ringrazio tutti i colleghi intervenuti a questa giornata dedicata alla Guida generale.
Le mie osservazioni si incentrano su alcuni problemi metodologici che, come redattori centrali dell'opera, abbiamo affrontato oltre venticinque anni fà e sull'opportunità di raccordarli a questioni che solo in anni recenti stanno diventando oggetto di dibattito.
Specie con l'introduzione dell'informatica si è sviluppata una discussione limitata soprattutto alla ricerca di criteri uniformi di descrizione, concentrando quindi l'attenzione sul tracciato della scheda e trascurando invece la discussione sui contenuti concettuali, sulle premesse e sul percorso metodologico per arrivare a elaborare le definizioni e i dati con cui riempire i campi delle schede.
Anche per l'elaborazione della Guida generale è stato posto evidentemente il problema di stabilire criteri uniformi per la descrizione dei fondi: ne è derivata l'emanazione di una dettagliata circolare inviata a tutti gli Archivi di Stato nel 1969. Nel corso del lavoro sono state introdotte alcune modifiche alle norme iniziali ma, nel complesso, la struttura adottata e le regole per la descrizione si sono rivelate adeguate alla difficile impresa. Ciò è dovuto al fatto che per arrivare all'emanazione della circolare sono stati impegnati tre anni di lavoro per definire gli obiettivi scientifici dell'opera, per analizzare le difficoltà oggettive che sarebbero derivate dalla necessità di fornire in un quadro organico e sistematico realtà archivistiche tra loro molto differenti, per studiare infine le soluzioni archivistiche più opportune. Al centro dell'indagine archivistica è stata posta l'identificazione dei soggetti produttori, intesi quindi come prioritaria chiave di accesso, e di conseguenza la normalizzazione delle loro denominazioni ai fini dell'elaborazione degli indici.
La più recente redazione delle norme ISAD (International Standard Archival Description) ha introdotto un secondo file per l'identificazione dei soggetti produttori e la descrizione storica delle istituzioni distinto da quello della descrizione archivistica dei fondi quando carte di diversa provenienza siano finite in uno stesso fondo o carte della stessa provenienza abbiano avuto destinazioni diverse; è il segno che, alla prova dei fatti, è finalmente emerso che il nodo centrale, quando si affronta l'elaborazione di una guida o anche la descrizione di un fondo, è costituito dalla natura problematica del concetto di fondo, dalla complessità della sua struttura e dall'analisi del rapporto che sussiste tra gli archivi originari e i fondi quali ci vengono trasmessi dalla tradizione storica. Il bel saggio di Stibbe, che illustra le ragioni di questo secondo file mette anche in evidenza come, ai fini della ricerca in campo archivistico, la chiave principale di accesso sia costituita dalla corretta denominazione dei soggetti creatori(1).
È pertanto motivo di soddisfazione per i redattori della Guida generale constatare che i criteri elaborati trent'anni fa e oggettivamente utilizzati per la realizzazione dell'opera comincino soltanto ora ad emergere nel dibattito internazionale. Ancora oggi non viene invece chiaramente recepito il fatto che, nell'ambito delle fonti archivistiche, l'elaborazione degli strumenti di ricerca - sia nel caso dell'ordinamento e dell'inventariazione di un singolo fondo ma a maggior ragione se si tratta di censimenti e di guide - deve sempre avere a monte un chiaro progetto scientifico e un responsabile che si faccia carico delle inevitabili mediazioni concettuali necessarie per dare coerenza logica e uniformità alla presentazione delle informazioni, salvaguardando la specificità delle singole realtà documentarie.
Gli strumenti di ricerca approntati in epoche diverse dai soggetti produttori o dai soggetti, che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno riutilizzato documenti posti in essere in un diverso contesto istituzionale, possono riflettere specifiche finalità politico-amministrative e sono in ogni caso sempre espressione di una determinata cultura burocratica da cui emergono elementi utili alla storia dell'amministrazione. Alla stessa maniera gli strumenti di ricerca approntati presso gli istituti di conservazione nei secc. XIX e XX - quando cioè si è operata una frattura nella gestione degli archivi storici rispetto agli archivi amministrativi - riflettono la scelta scientifica sottesa ai criteri di rilevazione e di descrizione. Se si tiene conto da un lato degli influssi delle teorie storiografiche e dall'altra degli stretti legami che intercorrono tra l'evoluzione politico-istituzionale, il processo di formazione degli archivi e le norme per la loro gestione e pertanto dell'influenza che direttamente e indirettamente ne deriva sulla metodologia dell'ordinamento e della descrizione dei fondi, non ci si può stupire se nel nostro paese si siano consolidate tradizioni differenti.
Possiamo parlare di una scuola toscana o di una tradizione milanese, ma troviamo consuetudini archivistiche anche nel Regno delle Due Sicilie, nello Stato della Chiesa, nell'area veneziana o nello Stato sabaudo. L'unificazione dell'Amministrazione archivistica nel 1874 alle dipendenze del Ministero dell'interno lascia in realtà un ampio margine di autonomia agli Archivi di Stato che, in una prima fase, vengono istituiti nelle città capitali degli Stati preunitari. Nonostante il regolamento del 1875 tenda a delineare criteri comuni in tema di ordinamento, peraltro ribaditi nel regolamento del 1911, permangono tradizioni metodologiche diverse che si riflettono nel persistere di terminologie locali e in una differenziata e complessa interpretazione del metodo storico. Da questa articolata situazione scaturisce un dibattito teorico di alto livello scientifico che si sviluppa fino ai nostri giorni. Il programma di insegnamento delle Scuole di archivistica paleografia e diplomatica, allegato al già ricordato regolamento del 1911, pone esplicitamente l'accento sulla definizione di norme generali per l'uniformità nella redazione dei principali lavori archivistici. Nel corso degli anni si viene a predisporre dal centro una modulistica per la redazione degli inventari ad uso delle sale di studio al fine di uniformare le modalità di redazione, che poi però cade in disuso. Casanova nel suo manuale di archivistica enuncia lo stretto rapporto che intercorre tra il riordinamento del fondo e la compilazione dell'inventario che deve «rispecchiare, fotografare, se si potesse dire, in ogni sua parte il detto ordinamento e conservarne la struttura»; é rilevante questo riferimento alla struttura dell'archivio, ma il vincolare così rigidamente la descrizione di ciascun fondo alla struttura che emerge dal suo riordinamento dà luogo a soluzioni non facilmente comparabili, dal momento che la situazione oggettiva di ogni fondo - anche nei casi in cui sia il prodotto di magistrature rette da una normativa comune - può risultare diversa a seconda del processo di formazione e delle vicende occorse alle carte e può creare dei problemi soprattutto per comparare i dati di descrizione delle fonti.
Il fondo ordinato o riordinato va certamente descritto secondo la struttura individuata e la sequenza delle singole unità all'interno delle varie serie. Spesso accade però che carte di diversa provenienza, sicuramente riconducibili ad archivi diversi, siano confluite in un unico fondo, ed è corretto che vi rimangano incluse: in questi casi risulta certamente opportuno fornire, oltre alla descrizione che riflette l'ordinamento, anche apposite tavole in cui le serie risultino raggruppate e articolate per magistratura di provenienza, con l'attribuzione specifica delle rispettive date e consistenze.
Sotto il profilo metodologico i criteri di descrizione della Guida generale elaborati da C. Pavone e P. D'Angiolini operano una profonda innovazione, sganciando la descrizione dei fondi dalla loro configurazione fisica, ancorandola sempre tuttavia a dati qualitativi e quantitativi accertati. La Guida, dunque, si è proposta di identificare, nei limiti del possibile, i soggetti creatori delle carte, assumendoli come livello base per la descrizione, anche se di fatto la loro documentazione risulti in fondi o versamenti diversi, sia in conseguenza di interventi congrui o incongrui di riordinamento sia perché non ancora riordinati. Con la Guida, cioè, si è preso atto della non necessaria coincidenza tra gli archivi originari di ogni singola istituzione e i fondi quali si sono venuti a costituire nel corso del tempo, a secondo della loro specifica storia. Al tempo stesso però si è potuto constatare, dovendo dominare una quantità sterminata di fondi prodotti in contesti storico-istituzionali diversi, che l'elemento più certo per identificare la documentazione e per consentire comparazioni è rappresentato dall'individuazione del soggetto che in origine ha prodotto le carte.
Ne è derivato quello sforzo massiccio che abbiamo compiuto per conseguire una normalizzazione nei criteri di descrizione archivistica operando periodizzazioni, disarticolazioni e accorpamenti rispetto ai singoli complessi documentari. Questa impostazione nella presentazione dei dati non interferisce sul riordinamento oggettivo dei fondi, rilevabile peraltro dai rispettivi inventari, ma consente di ricostruire «sulla carta» e non «sulle carte» - oggi diremmo virtualmente - gli archivi originari, spesso attraverso una serie di mediazioni strutturali e di rinvii. Data la complessità dell'impresa riteniamo utile che i risultati conseguiti siano ora sottoposti a discussione.
L'aggettivo «virtuale» può far pensare a un sistema di libera associazione dei dati: non è in questo senso che va considerato il riordinamento «sulla carta». L'aggregazione virtuale delle singole unità archivistiche sulla base di una pluralità di chiavi di accesso, o meglio sulla base di domande che discendono da diversi ragionamenti, rientra nella dinamica di chi effettua la ricerca, nella prospettiva cioè dell'utente che può aggregare o disaggregare le informazioni secondo le esigenze della sua indagine. Un archivista che conosca il suo mestiere, invece, si propone sempre di ricercare e ricostituire i processi di sedimentazione delle carte, riscontrare le lacune, identificare le corrette provenienze in fondi complessi o nelle miscellanee o in fondi risistemati per materia, scoprire in quale altro fondo - conservato nello stesso istituto o in altra sede - siano in parte finiti serie o spezzoni di serie di un archivio: nell'ambito dell'analisi di queste vicende si procede di massima anche allo spostamento fisico delle unità archivistiche e alla loro risistemazione secondo l'ordine ricostruito. Se ragioni oggettive non consentono di riordinare anche fisicamente il fondo, si ricorre a una ricostruzione virtuale dell'archivio di un ente. Il riordinamento è essenziale all'archivista, tanto per ricostruire la storia dell'ente e lo scarto esistente tra norma e prassi quanto per valutare, sulla base della natura degli affari e della tipologia dei documenti, quale possa essere il livello più congruo di analiticità nella descrizione delle singole unità. Il fondo riordinato consente il recupero ai fini della ricerca di mezzi di corredo coevi alla produzione delle carte o comunque antichi; risulta inoltre consultabile anche attraverso strumenti di ricerca sommari, che tuttavia non escludono di procedere, se necessario, a più analitiche descrizioni in un momento successivo. Ma il riordinamento è fondamentale anche al fine di consentire allo studioso l'uso critico delle fonti.
Prima della Guida generale non esistevano opere - se escludiamo capisaldi della nostra tradizione, come la guida di Lucca del Bongi o quella di Venezia del Da Mosto o gli studi della FISA, che però non hanno uno stretto collegamento con le carte - che fornissero un quadro sistematico delle istituzioni italiane. Il lavoro di rilevazione operato per la Guida ha consentito ad esempio di ricostruire una prima mappa degli archivi oggettivamente esistenti degli organi centrali e periferici degli Stati preunitari e dello Stato italiano, di evidenziare la continuità istituzionale tra le ultime riforme sabaude e l'organizzazione degli organi centrali dello Stato italiano, di far emergere da fondi complessi le carte prodotte dalle istituzioni del periodo francese, di mettere a confronto le diverse soluzioni istituzionali verificatesi nel corso del sec. XVIII, o ancora elementi comuni nella costituzione degli Stati signorili, e la atipicità dello Stato della Chiesa rispetto a tutti gli altri ordinamenti, la diversa distribuzione di documenti medievali sul territorio, la ricchezza del materiale proveniente dalle corporazioni religiose. Ma al tempo stesso ha anche consentito di mettere in chiara evidenza le lacune, spesso non comprensibili, della documentazione pervenuta negli Archivi di Stato.
Nel progetto era previsto che ogni istituto provvedesse a elaborare tavole di raffronto tra le descrizioni elaborate per la Guida, i fondi e i versamenti quali oggettivamente risultano nei depositi e gli strumenti di ricerca interni o a stampa, che spesso a loro volta forniscono descrizioni peraltro non omogenee relative a insiemi di fondi o serie di diversa provenienza o limitate a singole serie o a versamenti parziali.
Il problema della definizione del fondo dunque è oggettivamente un problema complesso, spesso sottovalutato da chi teorizza senza una adeguata esperienza di lavoro sulle carte e senza una visione globale delle fonti. La definizione del concetto di fondo richiede di conciliare l'esigenza di una ricostruzione sincronica degli archivi prodotti dalle magistrature che operavano contemporaneamente nell'ambito di un ordinamento statale con quella della ricostruzione della dinamica interna propria di ciascun fondo archivistico.
Il riordinamento dei fondi o le nuove acquisizioni di carte possono ovviamente modificare dati e informazioni forniti in guide e inventari ma la provvisorietà dei risultati è propria del lavoro archivistico, come ben si evince da qualsiasi analisi comparata di strumenti di ricerca. Anzi, come si è rilevato, anche una diversa impostazione metodologica può non consentire il riconoscimento immediato di uno stesso fondo e ciò perché la scelta dei criteri metodologici costituisce a sua volta un fatto culturale in cui si riflettono orientamenti e principi teorici diversi che acquistano una ulteriore valenza interpretativa se collocati nel contesto storico in cui sono stati elaborati. Ne consegue, in ogni caso, che quando si procede all'elaborazione di ulteriori strumenti di ricerca relativi a fondi di cui esistono precedenti descrizioni è necessario raccordare, nei limiti del possibile, le informazioni mediante rinvii, tavole di raffronto o richiami in altra forma. Ciò risulta utile alla ricerca, sia perché in ogni caso si deve essere in grado di ritrovare le unità archivistiche, anche se si trovino organizzate o descritte in maniera diversa sia perché dalla rilettura di antichi o comunque precedenti strumenti di ricerca emergono informazioni estremamente utili alla storia dell'amministrazione. E' chiaro che ogni strumento di ricerca ha implicita la possibilità di essere superato da ulteriori strumenti di ricerca. Non è sempre detto però che uno strumento di ricerca moderno sia fatto meglio di quelli più antichi.
Ai fini di un controllo globale delle fonti archivistiche che includa anche le fonti non statali, conservate ai sensi della legge archivistica solo in piccola parte negli Archivi di Stato, dobbiamo inevitabilmente recuperare i soggetti produttori degli archivi e la loro corretta e uniformata denominazione: è opportuno partire dal livello minimo di informazione sul fondo e sulla sede di conservazione per fornire ai ricercatori un primo orientamento aggiornato e aggiornabile sul patrimonio archivistico disponibile. La Guida generale ha messo chiaramente in evidenza e in buona parte ha rilevato i mutamenti di denominazione nell'ambito delle istituzioni di governo ma analoghi problemi si verificano in tutti i casi in cui si siano operate concentrazioni o disarticolazioni di funzioni e di archivi: si pensi ad esempio ai comuni e in genere agli enti pubblici, alle imprese, alle istituzioni assistenziali, alle corporazioni religiose, agli ospedali, alle istituzioni scientifiche o infine agli archivi familiari e personali. In molti casi l'analisi per identificare i soggetti produttori delle carte è piuttosto difficile e una non meno avventurosa indagine serve per trovare le sedi di conservazione, specie per gli archivi privati, tenendo conto che nel campo delle fonti archivistiche anche la sede di conservazione può mutare nel tempo.
Il problema, dunque, della definizione concettuale del fondo, delle denominazioni corrette e uniformi dei soggetti che nel corso della storia hanno prodotto carte e della cui esistenza siamo a conoscenza, costituisce il primo passo per un uso efficace dell'informatica che si riveli effettivamente utile agli studiosi e non eccessivamente costoso. Non si tratta però di un problema che nasce con l'informatica o che si risolve con l'informatica: è un problema specifico e prioritario dell'archivistica e si rivela essenziale anche quando si usa l'informatica. E' dunque necessario, nella prospettiva di un sempre più largo uso dell'automazione, riflettere sui problemi teorici dell'archivistica e muoversi con consapevolezza in un ambito nel quale proprio gli sforzi compiuti per la Guida generale costituiscono una importante base di partenza.